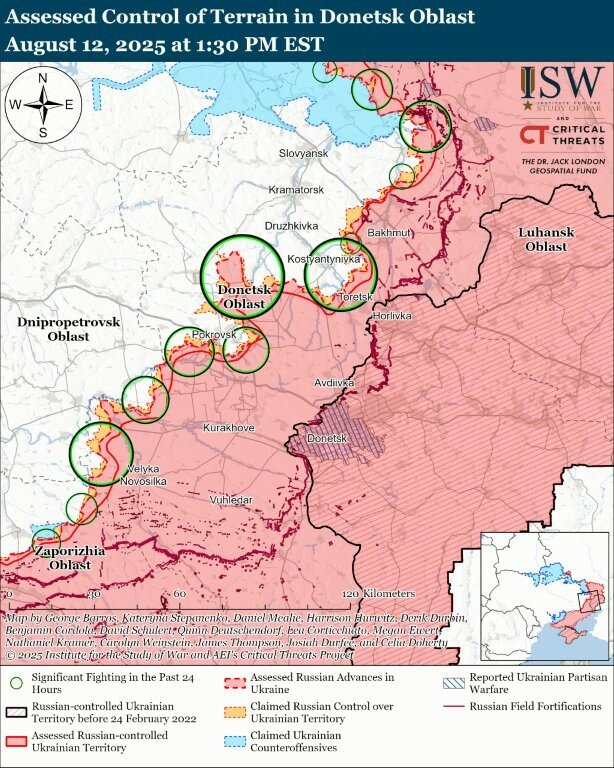Così anche per il denaro, ciò che sembrano le pressioni inevitabili del denaro in realtà si dissolvono quando si scontrano con qualcosa che è più consistente e nostro.
Questo confine tra capitalismo e altro si manifesta anche nella lotta politica: per eliminare un avversario si sottolineano quasi sempre i suoi interessi economici. Non solo la corruzione, ma anche a volte basta mostrarne l’interesse. Quando il profilo di un politico perde le connotazioni ideali e lo spessore umano, a definirlo resta solo il suo tornaconto, così egli precipita non solo ai nostri occhi, ma anche di fronte a tutta la nazione. Da paladini della destra o della sinistra, questi protagonisti degradano subito in personaggi meschini, come i parenti parodiati nel Gianni Schicchi di Puccini.
Questo ci è evidente anche sul piano privato: ognuno ha, presto o tardi, esperienza di una profonda obiezione verso qualcuno per come lo ha visto comportarsi con il denaro. In fondo, quell’obiezione ha la stessa radice della resistenza più astratta e politica al capitalismo. Anche senza fare progetti di società alternative, sappiamo avvertire quel qualcosa che in noi resiste, guarda oltre e legge con più finezza nei comportamenti umani, negli affetti e nella forza dei miti che sostengono gli orizzonti filosofici delle comunità. Questo “altro” rivela l’orizzonte corto del guardare solo nelle tasche, e ricrea la prospettiva più ampia e reale con cui vediamo il mondo. Se non siamo bambini viziati, alla perenne ricerca di un nuovo giocattolo, prima o poi i limiti del consumismo appaiono evidenti anche ai piccoli consumatori.
Per prendere il volo sappiamo che non ci si arricchisce , ma ci si innamora; per innalzarci tentiamo di superare un lutto, leggiamo buoni libri per essere migliori perché sappiamo che immaginare insieme a un poeta o un musicista mostra gli orizzonti ampi in cui si articola la vita, i luoghi in cui l’umano, come dice Nietzsche, riesce a cogliersi. È questo che cerchiamo nella lettura.
Di questo scontro quotidiano tra noi e il capitalismo siamo tutti attori. A volte pare che la nostra civiltà, dagli ospedali alle università alle case editrici, sia governata esclusivamente dal denaro. Invece, quel qualcosa che obietta sempre ci ricorda che negli ospedali si curano le persone, nelle università si disciplinano e trasmettono i saperi, e nelle case editrici si cerca di pubblicare ciò che fa attrito con il proprio tempo e coltiva l’umano.
Essere umani, alla fine, è proprio una questione di resistenza. L’illusione di essere sollevati dalle nostre difficili condizioni storiche attraverso la ricchezza ci avvolge alle caviglie come un serpente, ma non sentiremmo il disagio, la falsità di questa promessa e il dolore della nostra condizione se non ci fosse qualcosa che, invece, guarda in alto, e che nell’altro — umano, animale o albero — vede vita. Che, nelle terribili guerre e distruzioni in giro per il pianeta, non riconosce nell’interesse che alimenta il male il vero disastro: la cupidigia dell’industria petrolifera o di quella delle armi. Riconoscere, invece, un “noi” che include alberi e fiumi, gli altri, il cielo e la terra vuole, al contrario, la fine delle guerre. Perché alla fine il capitalismo, che nasce come lotta alla povertà, si riduce a questo: la povertà. Guardiamo così le lotte dinastiche delle grandi famiglie di capitalisti come storie di grande infelicità, mal mascherata da case di lusso e barche costosissime, ma sostanzialmente storie di povertà assoluta, propaganda per la povertà di bambini che non possono essere consolati neppure da una navicella per andarsene su Marte.