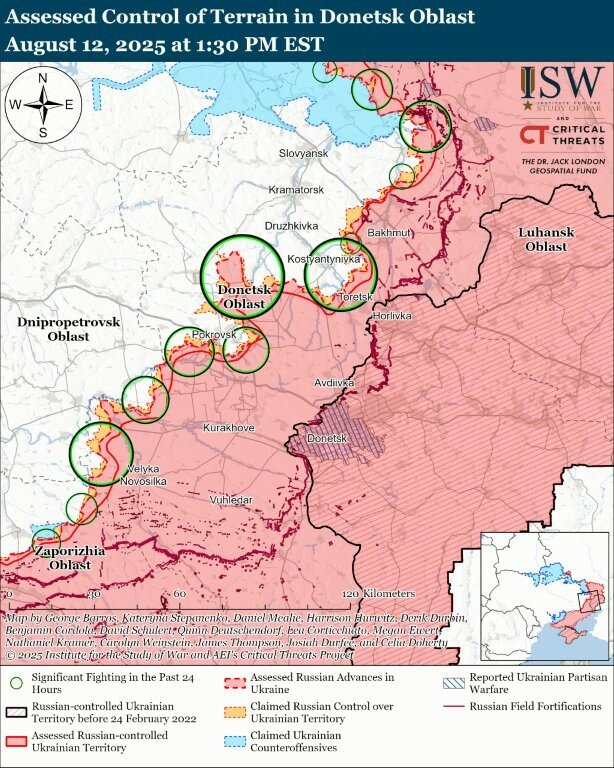Presentazione del racconto collettivo – La Memoria Dimenticata
Un'opera nata dall'intelligenza collettiva della comunità ACAiM
Come Associazione Culturale Cittadini Attivi in Movimento, siamo felici di condividere con voi i primi quattro capitoli, (il resto della storia sarà pubblicato nel sito web di Acaim ogni lunedi), di La Memoria Dimenticata, un racconto romanzato nato dall'incontro tra passione civile, memoria storica e sperimentazione narrativa collettiva.
Questa storia non ha un solo autore. È il frutto di una scrittura condivisa tra soci e attivisti della nostra comunità, un esercizio di intelligenza collettiva, di ascolto e confronto, che dimostra come sia possibile creare cultura attraverso il dialogo tra sensibilità diverse. Le voci che compongono questo racconto si intrecciano come fili in un tessuto: ognuna conserva la propria unicità, ma insieme danno forma a qualcosa di più grande.
Attraverso la vicenda di Luca, giovane studente inizialmente indifferente alla storia della Resistenza, ci interroghiamo su cosa significhi oggi "ricordare". La memoria che attraversa queste pagine non è solo uno sguardo al passato, ma una chiamata all'impegno presente: un invito a riscoprire il valore della partecipazione, della solidarietà, del coraggio di cambiare.
La Memoria Dimenticata è il primo esperimento narrativo che pubblichiamo come ACAiM, e per noi rappresenta un seme. Un seme di narrazione collettiva, di ricerca politica e culturale dal basso, che speriamo possa crescere grazie al contributo di chi legge, commenta, propone, partecipa.
Invitiamo tutti a leggere, discutere e, perché no, scrivere insieme a noi i prossimi capitoli di questa e di altre storie.
ACAiM – Associazione Culturale Cittadini Attivi in Movimento
www.acaim.it | cantierepolitico.it
Titolo: La Memoria Dimenticata
Capitolo 1: Il compito
Era un pomeriggio grigio, e Luca guardava il cielo dalla finestra della biblioteca. Si trovava in quel luogo, ormai frequentato da pochi appassionati, perché l'informatica (veloce, gratuita, immediata, democratica) aveva da tempo soppiantato la "ricerca" scolastica e il suo modo di gestirla. Era rimasto incuriosito dalle parole della sua insegnante, che gli aveva detto: "Prova a fare una 'ricerca' come si faceva qualche decina di anni fa, provate a visitare le 'Biblioteche' e scoprirete un modo di avvicinarvi alle informazioni, diverso da come si fa oggi." Si convinse, incuriosito, e quel pomeriggio si recò presso la Biblioteca della Memoria, che si trovava a pochi passi da casa sua. Lì fuori il mondo sembrava sospeso, come il suo interesse per quel noioso progetto di storia che gli pesava come un macigno.
«Scusi… è libero questo posto?» chiese una voce roca ma gentile.
Luca alzò gli occhi. Davanti a lui, un uomo anziano con una cartella di cuoio vissuta e lo sguardo curioso.
«Sì, certo.» rispose Luca, spostando i libri svogliatamente.
L’uomo si sedette, aprì la cartella e ne tirò fuori un libro consunto: “Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana” esclamò con enfasi facendo finta di leggere.
«Le interessa la storia?» chiese, senza distogliere lo sguardo dalla pagina.
Luca fece una smorfia. «Sto preparando una presentazione sul 25 Aprile, ma non è il mio forte. Non capisco perché dobbiamo tornare sempre su quella roba… sono passati ottanta anni»
L’uomo chiuse il libro con un sospiro. «Ottanta anni fa, sì. Ma quella "roba" è il motivo per cui puoi dire ciò che pensi, oggi.»
Luca lo guardò meglio. «Lei è un professore?»
«Lo ero. Rossi. Insegno ancora, ogni tanto, quando qualcuno ha voglia di ascoltare.»
Fu l’inizio di qualcosa. Nei giorni seguenti, Luca tornò alla biblioteca più per le chiacchierate con il Prof. Rossi che per il compito. Il professore lo portava in un viaggio fatto di racconti, di lettere scritte con le mani sporche di terra e sangue, di decisioni prese in un battito di cuore tra la paura e la speranza.
Poi arrivò lei.
Capitolo 2: La voce di Giulia
Era una mattina limpida, ma l’aria conservava ancora la freddezza dell’inverno. Luca uscì dalla biblioteca con un fascicolo sotto braccio: lettere partigiane, appunti del Prof. Rossi e un senso di qualcosa che stava cambiando dentro di lui, anche se ancora non lo sapeva.
Attraversando la piazza, vide un piccolo gruppo di persone davanti al municipio. Alcuni tenevano striscioni. Una ragazza parlava a voce alta, microfono alla mano, con la sicurezza di chi non ha paura di essere ascoltata.
«La memoria non si cancella con una mano di vernice!» disse. «Togliere la targa del partigiano Franco Serino non è solo un’offesa alla sua storia. È un’offesa a tutti noi!»
Luca si fermò, colpito dalla sua voce.
«Scusa,» chiese a uno dei presenti, «chi è lei?»
«Giulia. Fa parte dell’ANPI giovani. È tosta. Suo padre era partigiano. Ha fatto la guerra vera.»
Il discorso continuava. Giulia parlava di scuole dove non si insegnava più l’antifascismo, di lapidi ignorate, di silenzi pericolosi.
Dopo, mentre la gente si disperdeva, Luca si avvicinò.
«Parlavi davvero bene, sai?»
Giulia si voltò e lo squadrò da capo a piedi. «E tu chi sei? Un giornalista? Un altro curioso?»
«No, solo… uno che sta cercando di capire. Mi chiamo Luca.»
Lei lo fissò per un istante, poi sorrise. «Beh, almeno sei onesto. E se stai cercando di capire, potresti venire a una riunione. Non sono lezioni, se è questo che temi.»
«Più che altro temo di sentirmi ignorante.»
«Lo siamo tutti, finché qualcuno non ci racconta la verità.»
Quel giorno, Luca capì che non bastava leggere le lettere dei condannati a morte. Bisognava anche ascoltare le voci dei vivi.
Capitolo 3: Le domande giuste
La stanza del professore profumava di libri antichi e polvere. Non era un'aula vera e propria, ma una vecchia sala concessa dal circolo culturale cittadino. Sulle pareti, manifesti sbiaditi della Resistenza, fotografie in bianco e nero di giovani con il fazzoletto rosso al collo, e una cartina dell’Italia del ’44.
Giulia era seduta a gambe incrociate sul pavimento, assorta nella lettura di un volantino.
«Il Sindaco vuole sostituire il nome di Piazza della Libertà con Piazza dell’Unità Nazionale.» disse senza alzare gli occhi.
«Un bel modo per annacquare tutto,» sbuffò Rossi, sistemando i suoi occhiali, «come se l’unità si potesse costruire dimenticando da dove veniamo.»
Luca ascoltava, seduto al bordo di una vecchia poltrona. Non parlava, prendeva appunti, faceva domande. Sempre di più.
«Ma… davvero c’è gente che pensa che la Resistenza sia stata una guerra civile tra pari?»
Giulia lo guardò dritto negli occhi. «Sì. E non è un errore, è una strategia. Se tutto si equivale, nessuno ha più responsabilità. I carnefici diventano solo “uomini in un momento difficile”.»
Il Prof. Rossi annuì. «Ed è lì che la memoria muore. Non con la dimenticanza, ma con la distorsione.»
Luca rimase in silenzio per un attimo. Poi si alzò e iniziò a camminare per la stanza.
«Io… non voglio solo fare il mio compito, ormai. Voglio capire, voglio farlo capire anche agli altri. Voglio… fare qualcosa. Ma non so da dove cominciare.»
Giulia gli sorrise. «Hai già cominciato. Stai facendo le domande giuste.»
Rossi gli porse un piccolo libro rilegato a mano. «Questo è il diario di Mario Corsi. Aveva diciassette anni quando scriveva queste pagine. Ne aveva diciotto quando è stato fucilato. Leggilo. Non per sapere. Ma per sentire.»
Luca prese il libro con entrambe le mani, come fosse un oggetto sacro.
Fu in quel momento che il passato smise di essere solo storia. Divenne una chiamata. Un’urgenza. Una responsabilità.
Capitolo 4: La prima parola
L’aula magna dell’università era piena. Più del solito. L’associazione studentesca aveva organizzato un dibattito sul 25 Aprile: “Memoria o retorica?”.
Sul palco, accanto a un docente di diritto costituzionale e a un giornalista locale, sedeva anche Luca. Nessuno se lo sarebbe aspettato, nemmeno lui, fino a pochi giorni prima.
Dietro le quinte, prima di salire, aveva tremato. Giulia gli aveva preso le mani.
«Ricorda: non devi convincere tutti. Devi solo essere vero.»
Il microfono davanti a lui sembrava più grande della sua voce. Guardò il pubblico. Alcuni studenti lo fissavano distratti, altri prendevano appunti. C’era anche il Prof. Rossi in fondo alla sala. Annuiva lentamente.
Luca deglutì. Poi cominciò.
«Fino a poco fa, il 25 Aprile per me era solo un giorno festivo. Una sfilata con bandiere, una parola su un libro di storia. Poi ho letto. Ho ascoltato. Ho incontrato persone. E ho capito che la memoria non è un ricordo. È una scelta.»
Qualcuno si voltò. Altri iniziarono ad ascoltare.
«Scegliere di ricordare è scomodo. Perché significa riconoscere che la libertà non è data per scontata. Che c’è stato chi ha scelto da che parte stare. E che oggi, tocca a noi scegliere di nuovo: se vogliamo una memoria viva, o una comoda dimenticanza.»
Fece una pausa. Il silenzio in sala era denso.
«Ho letto lettere di ragazzi della mia età. Morivano per un’idea. Io non so se sarei capace di tanto. Ma almeno posso fare una cosa: posso non voltarmi dall’altra parte.»
Un applauso, timido all’inizio, poi più forte, riempì la sala.
Quando tornò dietro le quinte, Giulia lo abbracciò senza dire nulla. Il Prof. Rossi gli mise una mano sulla spalla.
«Benvenuto, ragazzo. Ora sei parte della Resistenza anche tu. Quella di oggi.»
Luca sorrise. Per la prima volta, sentiva che le sue parole potevano lasciare un segno.
… (segue)